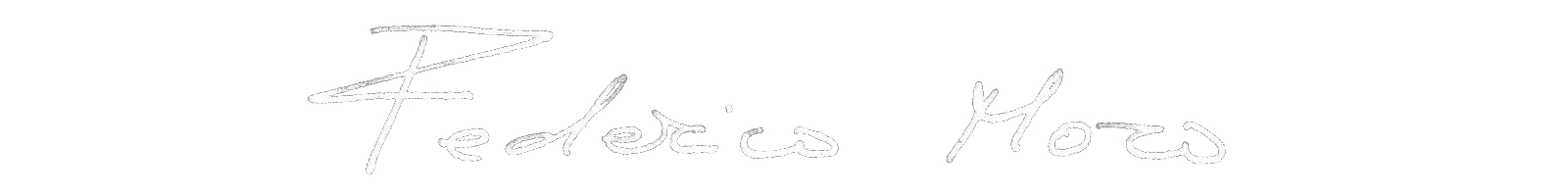Suella o Sue Ellen Braverman, Kemi Badenoch, Priti Patel: il lettore si chiederà chi mai siano. Rispondo subito. Sono tre deputate inglesi del Conservative Party. Le quali coltivano l’ambizione di diventare primo ministro, scalzando dalla posizione occupata l’insoddisfacente, per i conservatori soprattutto, Rishi Suniak. Prassi in uso non solo in Italia, come si vede. Dal momento delle ultime elezioni, generali, 2019, vinte con il 43,6% dal partito allora guidato da Boris Johnson, l’attuale capo del governo è il terzo in ordine di tempo. Senza essere più andati alle urne.
Il dettaglio interessante è che Rishi Suniak è il primo discendente di immigrati a raggiungere la carica. È infatti indiano e induista praticante. L’altro aspetto rilevante, però, è che anche le tre donne appena citate sono di famiglie immigrate a suo tempo. Suella Braverman, nasce in realtà Fernandes. I genitori sono entrambi indiani: il padre vanta un cognome portoghese, ma solo perché originario di Goa. La madre è una tamil induista proveniente da Mauritius. Kemi Badenoch, è figlia di Femi e Feyi Adegoke, nigeriani. È solo dall’età di sedici anni che vive stabilmente in Inghilterra. Priti Patel proviene da una famiglia di indiani del Gujarat, stabilitasi in Uganda e da lì emigrata in Inghilterra quando la situazione del paese africano si è deteriorata al punto da consigliare loro di partire.
Tutte e tre hanno alle spalle una lunga militanza politica nelle file dei conservatori, di cui hanno sempre sostenuto le politiche più intransigenti, in ultimo dalla Brexit a quelle sull’immigrazione. Più volte interrogata sul fatto che, applicando queste e le sue opinioni, ancora meno tolleranti in materia, al proprio caso la stessa Patel non sarebbe mai potuto entrare nel Regno Unito, la deputata e ministro degli interni non ha voluto, né saputo rispondere.
Suniak, Braverman, Badenoch, Patel hanno quindi in comune il fatto di essere conservatori oltranzisti pur uscendo da realtà dell’immigrazione. Il colore della pelle e la fede religiosa, Suniak rivendica con orgoglio il suo credo induista, non ha impedito loro di assumere valori e impegnarsi in favore di scelte politiche che la pubblica opinione collega d’istinto alla upper class britannica: bianca, anglosassone e affluente. Restando del tutto indifferenti alle loro contraddizioni esistenziali, anche quando svelate apertamente.
Facciamo un salto in un altro ambito, adesso. Theo “Bongi” Mbonambi si è di colpo conquistato l’attenzione mediatica di quanti cercano nelle pagine sportive un po’ di svago dal continuo bombardamento di guerre&sangue di giornali e notiziari. Purtroppo non per la sua prestazione, per altro al solito di alto livello, bensì per due parole lanciate contro uno degli avversari di turno, vale a dire l’inglese Tom Curry. Mbonambi era in quel momento, oltre che tallonatore della mischia degli Springboks anche il capitano della squadra sudafricana. Curry, terza linea, invece si trovava dall’altra parte. Particolare sportivo: partita accesissima, vinta all’ultimo secondo dai Boks con un calcio prodigioso del loro mediano, Handré Pollard. Disperazione del XV della Rosa. Esultanza sudafricana per la quarta finale di Coppa del Mondo raggiunta. Dettaglio cromatico: bianco di pelle e di maglia Curry, nero di pelle e verde di maglia Mbonambi.
Insomma, cosa ha mai detto Mbonambi? Premesso che nelle mischie se ne gridano di tutti i colori e altrettante se ne fanno, comunque sia pare abbia urlato a Curry “white cunt”. Il che ha un significato più che letterale. “Fighetta bianca”, infatti, è espressione comunque forte nella lingua di Shakespeare, perché assume connotati di rudezza quasi incomprensibili a noi latini, ma nella sua versione “black” è ben noto insulto razzista. Ovvio l’episodio abbia catalizzato l’attenzione generale. Qualcuno si è spinto a titolare “Il mondo alla rovescia”, perché del razzismo dei neri verso i bianchi non si era mai sentito parlare.
Lo storico che è in me si è subito messo a sorridere. Il lettore di stampa internazionale ha rincarato la dose. Nella faccenda, infatti, non c’è proprio nulla di nuovo o di sorprendente. Sbaglia chi si abbandona agli stereotipi. O all’ideologia malamente utilizzata. Il razzismo è una mala pianta che da sempre alberga ovunque e non appena se ne presenti l’occasione coglie l’attimo per manifestarsi. Dentro uno stadio o nella vita di ogni giorno. In Sudafrica, Arabia, Cina, Congo, Indonesia, dove preferite voi. Non cambia nulla. Perché obiettivo dell’odio è l’”altro”, il diverso, il portatore di valori che si temono e non c’è nessuna appartenenza, etnica e/o politico-religiosa, che possa salvare in sé e per sé. Ognuno deve farci i conti di persona. Vale lo stesso per qualunque schema valoriale. Perché ricollegare l’adesione ad alcuni principi a delle condizioni di fatto, “oggettive” e/o “strutturali” direbbero i vetero marxisti oggi tornati di moda, è senz’altro comodo, ma del completamente sbagliato. Ognuno i suoi principi se li sceglie: con atto di volontà propria, non per nascita o condizione socio-economica.
Quindi anche Rishi Suniak, Suella Braverman, Kemi Badenoch, le due deputate e diverse volte ministro usano i cognomi dei mariti tra l’altro, Priti Pratel e Theo “Bongi” Mbonambi, rugbista di vaglia e nero di pelle. Nessuna delle due caratteristiche lo hanno preservato da un comportamento razzista. Se il suo “nemico” del momento è un terza linea bianco, allora “white cunt” esplode senza remore. Aggiungiamoci, poi, che Curry è pure inglese e indossa una maglia bianca, avversata come poche in Sudafrica: perché è quella dei colonialisti di un tempo, dei padroni delle miniere e di ogni ricchezza nell’immaginario di molti. Un dato che probabilmente accomuna sotto la medesima casacca verde sia Mbonambi che Pollard, un nero e un bianco afrikaaner di ascendenza franco/ugonotta, di quanti cioè fuggirono dal Vecchio Continente per edificare altrove il Regno di Dio. Impiantandovi i loro tribunali religiosi e infliggendo le medesime torture e condanne della lontana madrepatria. I roghi si sono usati sempre ovunque e pure l’impalamento per uccidere aumentando le sofferenze. Un tempo in tutta Europa, ancora oggi in buona parte del Pianeta. È delle anime candide, poco informate o avvelenate dalla propaganda ritenere il contrario.
Gli afrikaaner, dunque. Sentina di ogni vizio e abisso razzista secondo i progressisti a ogni latitudine. Parola di Allister Haddon Sparks (1933-2016), scrittore, giornalista e commentatore politico sudafricano, autore tra l’altro di The Mind of South Africa, libro di una certa taglia con la pretesa di fornire una ricostruzione storica della complessa vicenda di quel paese e, soprattutto, di indagare le ragioni profonde dell’apartheid. Quando lo scrive, infatti, non è ancora intervenuto la svolta del 1994 con Nelson Mandela presidente. Secondo Sparks, sudafricano anglofono di famiglia inglese trasferitasi dalle parti di Città del Capo all’inizio dell’Ottocento, la responsabilità di fondo risiede nel nazionalismo afrikaneer, alimentato senza tregua dalla visione dogmatica inculcata nelle giovani generazioni dalla Chiesa Riformata d’Olanda. La quale ha avuto buon gioco, avendo a che fare con le deboli menti di discendenti di contadini dei Paesi Bassi. I quali, gli olandesi, ovunque hanno dimostrato un tasso di razzismo e di violenza senza uguali. In particolare a Sumatra nell’odierna Indonesia. Afferma Sparks. Nelle prime pagine, il nostro arriva a sostenere che per il Sudafrica sarebbe stato molto meglio finire nell’orbita dell’Impero Portoghese, perché i latini sono esenti dalla fanatica durezza di quei discendenti di calvinisti ignoranti.
Da italiano e quindi latino potrei anche sentirmi gratificato da tale osservazione, dopo di che forse varrebbe la pena ricordare che portoghesi prima, spagnoli poi, sono stati i grandi trafficanti di schiavi in ogni parte del Globo dove le loro caracche, caravelle e galeoni siano arrivati. Nell’America settentrionale, dove il problema razziale non è mai stato davvero risolto, gli olandesi e i loro discendenti rappresentano un’esigua minoranza. Anche se si deve a loro la fondazione della città simbolo degli Usa, New York nata Nieuw Amsterdam. Di origine olandese due presidenti di enorme rilevanza nella storia americana, Theodor e Franklin Delano Roosevelt. Tra l’altro cugini di quinto grado. Detto questo, le grandi piantagioni di cotone funzionanti con manodopera servile non sono state certo opera di coloni olandesi e calvinisti, bensì per lo più inglesi, anglicani o battisti. Con buona pace di Sparks.
Il quale non si limita a questo, ma aggiunge pennellate di idilliaca Arcadia “nera” quando descrive il mondo tribale, che si scontra con le orde di cavallette arrivate dall’Europa. Società pacifiche, accoglienti e inclusive attonite e ferite dall’impatto con i draghi olandesi. Perché, sia ben chiaro, gli inglesi non hanno mai fatto nulla. In ogni caso, zulu, xhosa, sotho, tswana, tsonga, swazi, venda, ndebele, pedi per non parlare dei mitissimi boscimani san e khoi, sono stati tutti, indistintamente, vittime dell’avidità di terre dei trekboers o semplicemente boeri. Potremmo essere tentati di crederci, se non sapessimo che le cose sono andate in modo diverso. Basterebbe evocare lo spettro del sanguinario impero zulu del leggendario Shaka, il quale a cavallo tra Settecento e Ottocento crea uno stato espansionista che conquista armi alla mano gran parte dell’Africa meridionale. Anche perché strutturato in modo da alimentare e sostenere un esercito senza eguali per dimensioni e livello di addestramento. Pare si debba a lui l’innesco del vasto movimento migratorio chiamato Mfecane: una successione ininterrotta di guerre interafricane condotte con estrema brutalità. In particolare, era previsto lo sterminio dei maschi, combattenti o meno, e l’asservimento di donne e bambini degli sconfitti. Il tutto in un avvitamento senza fine. Nella faccenda nessun bianco, olandese o portoghese, pare c’entrarci alcunché. A parte i lusitani per via indiretta, in quanto colpevoli di aver introdotto in Mozambico la coltivazione del mais, accendino economico dell’imperialismo zulu.
Una ricostruzione contestata da Julian Cobbing, il quale nel 1988 sostenne che a mettere in moto il Mfecane, le cui esistenza e dinamiche sono inconfutabili, fu l’aumentata richiesta di schiavi da parte dei soliti europei, in particolare dei portoghesi del Mozambico. Quindi, l’Impero Zulu sarebbe nato come reazione difensiva di fronte alla pressione esercitata in tal senso sulle popolazioni africane. Peccato che Shaka e discendenti, fino all’arrivo dei soliti boeri e inglesi che ne volevano prendere il posto, si rivolgessero principalmente contro gli altri popoli neri. Al di là di tutto, bisognerebbe però cominciare a rispondere con onestà a una banale domanda: chi forniva gli schiavi? Perché a comprarli e trasportarli ci pensavano arabi nell’Oceano Indiano, portoghesi & Co. un po’ dovunque, ma non risulta da nessuna parte che gruppi di razziatori bianchi penetrassero all’interno per catturare la “merce” necessaria. E allora? La verità è che la tratta avveniva sulla costa e qui le vittime venivano vendute da bande di guerrieri africani, i quali portavano lì non soli nemici vinti in battaglia, ma anche e soprattutto gli indifesi che erano riusciti a rapire. Un po’ dove capitava. Nessuna domanda si crea se non esiste possibilità di soddisfarla. E a catturare e vendere gli africani erano altri africani. Per sete di guadagno. Agli arabi, in prima istanza, da sempre utilizzatori su larga scala di schiavi: neri o bianchi non aveva importanza. La stessa parola, “schiavo”, deriva in definitiva dall’etnomino slavi, in quanto preda preferita di tali commerci sin dalle lontane origini e sottomessi per questo, molto a lungo, ai loro signori turcofoni, i nomadi delle steppe àvari. Slavi: bianchi e molto spesso biondi o rossi di capelli. Particolarmente ricercate le donne per tali ragioni.
In realtà, in Sudafrica l’Impero Zulu è stato battuto sul campo da boeri e inglesi, altrimenti sarebbe dilagato occupando l’intero spazio compreso tra i due oceani, Indiano e Atlantico. Perché questa è la vocazione degli stati, di qualunque origine e radice etnica siano: egemonizzare i vicini, quindi assorbirli all’interno di una compagine più vasta, infine espandersi fino a quando, tendenzialmente, diventano ingovernabili a causa di dimensioni e lotte intestine oppure perché conoscono la sconfitta contro un avversario più tosto e meglio organizzato. Oppure solo fortunato. Fosse andata diversamente, semplicemente avremmo avuto in Sudafrica dominatori neri, che avrebbero imposto una sorta di apartheid ai bianchi vinti. Sulla falsariga di quanto fatto dagli àvari con gli slavi ed è accaduto nella Cina del Celeste Impero o nel Giappone del Sol Levante: fino a quando sono stati aperti al Mondo dai cannoni inglesi e dalle navi del commodoro Perry, rispettivamente. Con la forza, cioè. Apartheid, cioè separazione: quello che in Cina i Mongoli vittoriosi imposero agli Han conquistati. E asserviti. Nonché drasticamente ridotti di numero. Anche se oggi è diventato di moda sostenere che il calo della popolazione, più o meno dimezzatasi, indicherebbe più un fallimento burocratico, nel sistema di registrazione, che altro. Apartheid, quello che gli Ostrogoti, germani e ariani, cercarono d’imporre nella Penisola agli Italici, latini e cattolici. Poi il numero ebbe ragione di tutto.
Conclusione. Sul Pianeta i buoni per definizione non esistono. Appartenenza etnica, ideologia e/o religione non portano di per sé ad abbracciare alcuni valori invece di altri. Nella prassi quotidiana, ci sono i forti e i deboli. I primi dominano i secondi. I quali quando diventano forti, semplicemente, tendono a rovesciare il rapporto, occupando in toto la posizione degli sconfitti. Come ricordavo nel precedente articolo, La Grande Offensiva, e aveva già detto Tucidide nel V secolo p.E.C. mentre Macchiavelli l’ha ripetuto fino alla nausea nel Cinquecento. Non sarebbe una cattiva idea dare loro ascolto. Ho l’impressione che se ne intendessero. Così la smetteremmo di stupirci di Suniak, Braverman, Badenoch, Patel e del “fighetta bianca” sibilato da Theo “Bongi” Mbonambi addosso a Tom Curry. Cominceremo anche a capire che i 450.000 squatters bianchi oggi nei campi improvvisati in Sudafrica non rappresentano una singolare anomalia, rappresentano circa il 10% di tutti i bianchi del paese, bensì la diretta conseguenza della conquista del governo del paese da parte della maggioranza nera: il loro non è il “colore giusto” oggi laggiù. Siamo nel campo dell’ecologia degli stati. Se continuiamo a restare in tale ecosistema, prima di combinare disastri e di trovarci come gli italici di lingua latina alle prese con i nuovi padroni ostrogoti e longobardi sarebbe bene rifletterci. E magari sapere cosa è già successo. Non è un discorso di “destra”, ma di corretta valutazione storica. La storia non deve mai sostenere una tesi ideologica, perché semplicemente “è”, anche quando non ci piace.