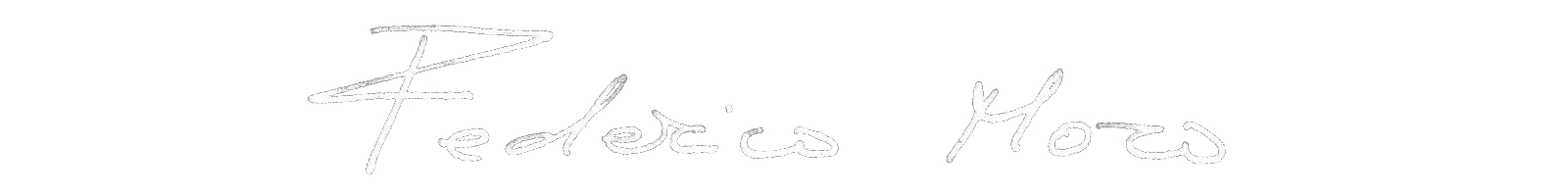Il referendum sulla separazione del Comune di Venezia in due realtà distinte, Acqua e Terra, è alle spalle. L’esito, imprevisto nelle proporzioni, dovrebbe porre fine per un po’ a un dibattito che si trascina, sempre più stancamente, da quarant’anni. Già, perché tra la prima e l’ultima delle cinque consultazioni in materia, 1979 e 2019, sono intercorsi esattamente quattro decenni. Anche per le nostre abitudini, un arco di tempo adeguato a pronunciare l’unica parola sensata: basta.
Archiviate le opposte polemiche, vediamo di tornare ai problemi veri. Perché, questi sono tutti sul tappeto e nessuna alchimia di natura amministrativa li può risolvere con un colpo di bacchetta magica. Opportunità negata anche alle elezioni del prossimo anno, sia chiaro. Per cominciare ad affrontarli serve, invece, qualche idea. Provo a buttarne qualcuna.
La “questione Venezia” parte da un dato culturale al quale non si può sfuggire, pena l’inconsistenza di ogni proposta: l’identità della città. La quale, come qualunque in ogni parte del mondo, non è affatto un dato acquisito, scolpito per così dire dall’ambiente geografico e antropologico, ma è sempre frutto di una scelta consapevole. Si diventa ciò che si è deciso di essere. Ovunque.
L’affermazione merita qualche prova a sostegno. La migliore ce la offre proprio la storia della città. Perché questa realtà in formazione compie a un certo punto il passo che la caratterizzerà in modo definitivo, barattando la terra, che non aveva, con l’acqua, dalla quale era circondata. Opzione difficile da percorrere, perché gli uomini non sono pesci e il loro ambiente naturale non è il mare. Tanto complicata da costringere a sviluppare una cultura specifica, la quale poi doveva venire insegnata a un’intera popolazione e trasmessa alle generazioni successive[1]. Senza alcuna speranza di assimilazione definitiva, proprio perché il mare non è scontato per l’animale uomo. Basta interrompere la catena per una/due generazioni e il patrimonio alla base della “marittimità” viene disperso. Esattamente quanto accade qui a partire circa dalla seconda metà del Seicento.
Venezia, dunque, “scelse” il mare, diventò stato e quindi grande potenza marittima e su tale base modellò la propria idea di sé, dotandosi di un modello urbanistico “marittimo”. Non per caso si sprecano definizioni quali “città anfibia”, “città d’acqua” e via dicendo. Per conservarsi tale promosse giganteschi lavori idraulici, di dimensioni da far impallidire qualunque Mo.S.E.. La renovatio urbis in senso romano classico, promossa per primo dal doge Andrea Gritti e proseguita, in sostanza, sino ai giorni nostri, si è proposta quale alternativa radicale, dando per acquisita la perdita della dimensione marittima della città e cercandone un’altra, diversa.
Noi, oggi, ci troviamo di fronte alla stessa domanda di fondo di un tempo: cosa vogliamo essere? Città marittima o di terra? Perché dalla risposta dipendono le soluzioni. Passiamo al concreto.
Se la scelta è “marittima” non si può prescindere dal porto. Solo l’essere inserita nelle Sloc[2] su cui scorre il commercio a lunga distanza darebbe sostanza e senso a tale opzione. Allora, qualunque via si decida di percorrere deve privilegiare l’esistenza e il buon funzionamento del porto. Il quale, per via delle dimensioni delle navi e dell’ormai inevitabile innalzamento dei mari, eustatismo amplificato a dismisura dal cambiamento climatico, dovrà essere esterno all’attuale laguna e quindi “d’altura”. Portando alla realizzazione delle inevitabili infrastrutture. L’opzione “marittima” consente la completa salvaguardia della città così com’è nata e si presenta oggi, nonché di una qualche laguna, anche se di sicuro molto diversa dall’attuale. Da dimenticarsi quella del passato. Il tutto grazie a un sistema di barriere, ben più “fisso” e invasivo di quanto il Mo.S.E non sia o sarà mai. L’acqua, però, rimarrà. In qualche modo.
Il pregio di tale soluzione è quello di mantenere la natura “marittima” della città e quindi la relativa cultura che produce una società aperta, inclusiva, flessibile, dinamica, innovativa, tendenzialmente democratica ed egualitaria. Il difetto è che viene sacrificato l’ambiente quale lo conosciamo.
Quindi dei quattro termini in gioco, salvaguardia della città, della laguna, della funzionalità del porto e “invisibilità” delle opere, vale a dire il quartetto che ha “costretto” a progettare il Mo.S.E. sommerso, il primo e il terzo, sicurezza della città e del porto, sono assicurati, mentre il secondo e il quarto, laguna e invisibilità, sono sacrificati. D’altronde, e qui rimando agli studi e molteplici interventi di D’Alpaos e Seminara per esempio, coniugarli tutti in contemporanea è impossibile.
Non piace? L’unica alternativa possibile è quella di “terra”. Sempre partendo dal dato dell’innalzamento inevitabile delle acque, per evitare la perdita della città si dovrà chiudere in via definitiva ogni via liquida e quindi trasformare la laguna in terraferma. Qualcosa del genere di quanto è successo nel tempo a Ferrara, Mantova, Ravenna. La linea di costa dovrà comunque essere difesa da colossali opere che la tengano all’asciutto. Dal Delta del Po a Trieste, probabilmente. Secondo tale opzione, Venezia verrà salvaguardata, ma non così la laguna e neppure il suo porto se non si percorre l’opzione d’altura.
La scelta “di terra” produce di per sé solo la salvaguardia della città, anche se in forma del tutto diversa dall’attuale e con perdita finale della sua dimensione marittima.
In entrambi i ragionamenti, si sarà notato, la grande vittima è la laguna. Voglio essere chiaro su tale aspetto. A mio parere non ci sono speranze di salvarla così com’è. Ogni laguna al mondo del resto, è soggetta a un destino ineluttabile: o diventa baia, cioè mare, oppure s’interra. Quella veneta, che in Antichità non c’era e sarebbe bene ricordarlo, è già durata molto tempo proprio grazie alla precisa volontà dell’uomo di conservarla. Per l’esattezza di mantenere la dimensione “marittima” della città sorta nel frattempo al suo centro. Venezia, appunto. Questo il fine degli interventi del passato, in particolare di quelli incredibilmente invasivi condotti a termine sotto la direzione del celebre Cristoforo Sabbadino il “Moretto”, tanto spesso citato e quasi sempre a sproposito. Per non parlare del leggendario Taglio di Porto Viro, quando la repubblica arrivò al punto di deviare lo stesso fiume Po. Una bazzecola, come si può intuire.
Oggi la sfida è di dimensioni maggiori perché in gioco c’è la sopravvivenza fisica della città. Possiamo affrontarla cercando di recuperarne la natura marittima oppure cancellandola per sempre, in ogni caso qualcosa dovrà essere sacrificato. Bisogna rendersene conto. In fondo, la colpa principale del Progetto Mo.S.E., ladrocini a parte che sono altra questione, è consistita nel tentativo di risolvere con un colpo d’ali quattro tematiche in contrasto tra loro.
E lasciamo stare per una volta i discorsi che non c’entrano con la questione, come i flussi turistici o l’aumento di alberghi e b&b: per affrontare i problemi bisogna concentrarsi sul nocciolo e non disperdersi, finendo per buttare gli argomenti più diversi dentro un unico, indistinto calderone. Purtroppo, uno dei nostri vizi con maggiore tradizione e fortuna.
La parola a chi legge: cosa ne pensate?
[1] Il discorso sulla “cultura marittima” fondamento poi di ogni stato marittimo è piuttosto complesso, per il quale rimando alla lettura del lavoro fondamentale in materia e cioè a Seapower States, di Andrew Lambert, un libro uscito nel 2018 per i tipi della Yale U.P.
[2] Sea-lines of comunication.