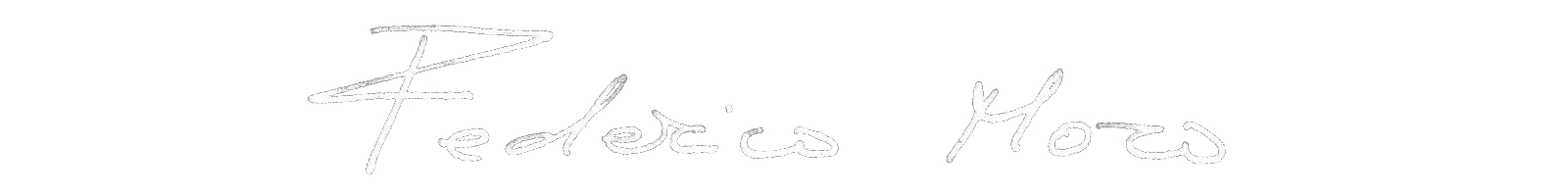Nell’ultima puntata, Dal dire al fare due, si è chiarito che Venezia “è” in quanto città-marittima capace d’intercettare le rotte commerciali a lunga distanza (Sloc), perché loro naturale terminale (Hub) all’incrocio intermodale con le vie fluviali e stradali (Corridoi) che penetrano nel cuore d’Europa (Adriatico-Baltico) o la collegano trasversalmente (Iberia-Ucraina). È sempre stato così nei secoli a partire almeno dal X prima dell’Era Comune (a.C.) per una banale questione geografica che si tende a dimenticare: l’arco alto-adriatico è il punto di costa più vicino al centro dell’Europa e si trova all’incrocio dei due citati assi, fluviali e stradali. Qui, da sempre, arrivano le rotte che saldano l’Asia con l’Europa e che noi dalla fine dell’Ottocento, sulla scorta del geografo tedesco von Richtofen, chiamiamo vie della Seta.
La geografia non ha solo determinato la vocazione principale di Venezia, ma ha proprio prodotto la città: prima non c’era e poi è sorta. Allo stesso modo dei suoi abitanti, una vera “nuova nazione” che nasce in un certo momento e contesto storico, sostituendo quelle prima stanziate nell’area. I Veneziani, infatti, hanno persino un nome specifico per auto-indicarsi, un nome che non c’è in precedenza, che serve a circoscrivere quanti appartengono alla nazione formatasi lungo la costa della Venetia: Civitas Venetiarum e non Venetorum, e non è un caso. Il porto, dunque, non è semplicemente da sempre la principale attività economica, con l’Arsenale in seguito quale suo principale effetto collaterale, ma è la città, in un certo senso la precede. Se non avesse un’origine indiscutibilmente militare, strutturata attorno al sistema fortificato tardo-antico da cui gemmano, in quanto centri agglutinati attorno alle singole installazioni militari, le varie comunità costiere, si potrebbe dire che prima venga il porto e solo dopo la città. La corretta successione cronologica, invece, colloca al primo posto la catena di torri e forti in origine tardo antichi e quindi alto medievali, poi il porto e quindi la città. Sorta a imitazione, urbanistica e funzionale, dell’antica Altino, non per niente con analoga vocazione.
Lasciando perdere il discorso fortificazioni, in quanto oggi mera curiosità storica, dobbiamo chiarirci cosa intendiamo con il termine porto, riferendoci alla Venetia e scopriremo che non è affatto scontato. Perché sin dalle origini ci troviamo di fronte a un porto diffuso, che si estende da Chioggia a Grado, interessando tutti i sorgitori fluviali dall’Adige alla Natissa e interessando anche il più meridionale Delta del Po. Questo è in realtà il porto della Venetia. Volendo, però, restringere il nostro campo di osservazione nello spazio, propriamente alla Laguna di Venezia, e nel tempo, diciamo dal XVI secolo in poi, osserviamo che l’espressione porto diffuso conserva intatta la sua validità. E non è questione di poco conto.
Noi, istintivamente, quando diciamo porto pensiamo a un’unica infrastruttura, vasta e articolata ma in buona sostanza concentrata in una determinata area. Il Porto di Venezia, oggi, per esempio, che presenta il solo Terminal Passeggeri staccato dal resto. Anomalia con ogni probabilità destinata a esaurirsi. In realtà in laguna non è mai stato così. In particolare a partire dall’affermarsi della navigazione a vela, ma soprattutto quando quella a remi viene definitivamente soppiantata. Il celebre porto della Serenissima risultava spalmato su larga parte della superficie lagunare, dove si cercava di sfruttare la presenza di isole adatte a ospitare magazzini e uffici, a svolgere le necessarie quarantene, ma soprattutto prospicenti tratti d’acqua profondi a sufficienza per permettere l’entrata sicura e l’ancoraggio delle nuove navi. Le quali erano di dimensioni e pescaggio di gran lunga superiori alle precedenti, a vela o a remi che fossero. Perché i fondali lagunari hanno sempre rappresentato il problema per eccellenza della realtà politica chiamata Venezia.
Da un lato l’anello d’acque a protezione delle isole veniva concepito in chiave strategica, motivo per cui si decise di trasformare un’area poco ospitale nella nuova, grande città-stato. Ovviamente, si erano resi necessari i primi, vistosi interventi idraulici: determinati soprattutto dall’imprescindibile necessità di evitare il destino ineluttabile dei lidi veneziani, vale a dire di venire integrati nella terraferma a causa dell’avanzata inesorabile della costa, per gli apporti dei tanti fiumi che finiscono in mare nell’arco compreso tra Delta del Po e Tagliamento. Giusto per limitarci: sono sette quelli principali ai quali aggiungerne altri minori. Tra questi, i due maggiori della Pianura Padana e Veneta, Po e Adige. Da qui, una lotta senza fine nella quale i veneziani impiegarono ogni risorsa intellettuale, tecnologica e finanziaria disponibile. Una massa critica nient’affatto modesta specie quando, siamo ormai nel Cinquecento, la Repubblica Serenissima dispone di risorse colossali e cantierizza, è il caso di dirlo, un intervento senza precedenti: mette a disposizione del Consultore della Acque Cristoforo Sabbadino, chioggiotto detto il Moretto, mezzi e potere illimitati per uno stravolgimento della laguna senza pari. Si tratta, infatti, di eliminare due delta, Brenta e Piave, spostando gli estuari ottenuti fuori dalla laguna. Di immettere, quindi, due fiumi, ancora il Brenta e il Sile, nei corsi rispettivamente di Adige e Piave. Di alzare un terrapieno o diga lungo l’intera parte meridionale interna della laguna, isolandola dalla stessa. Su di essa oggi core la strada Romea. Non è tutto, ma è abbastanza per parlare di manomissione estrema dell’ambiente perpetrata a un solo fine: evitare l’interramento, conservando l’insularità di Venezia al duplice scopo difensivo, la città risulta così ancora imprendibile per chiunque non domini il mare, e il suo prezioso porto, fonte di ogni entrata statale e privata.
Non è finita, però. Il lungimirante governo della Repubblica Serenissima, all’inizio del Seicento, si rende conto che i pur notevoli interventi di Sabbadino non sono bastati. Bisogna fermare il mostro che da meridione continua a scaraventare in laguna masse enormi di detriti e fango, cioè il Po. Detto e fatto, si procede a ridurre la Bocca da sempre principale e detta appunto di Venezia, a mera via secondaria perché il flusso viene deviato in quella che da allora diventa la maggiore, Tolle. L’opera, vale a dire l’alterazione dell’intero Delta, è nota come Taglio di Porto Viro. Le finalità restano sempre le medesime, strategiche e portuali, per conservare a Venezia la protezione delle acque e la loro utilizzabilità a fini navali.
I problemi, però, permangono. Soprattutto riguardo alla navigazione interna e quindi al movimento mercantile. L’interramento della laguna viene ridotto, ma non arrestato, soprattutto crescono le dimensioni delle navi, quindi i loro pescaggi. I banchi di sabbia esterni alle bocche di porto rappresentano già di per sé una difficoltà enorme per riuscire a entrare, dopo comunque si pone la questione degli ormeggi. Dove sistemare queste navi? Già a fine Seicento, ma in forma ancora maggiore nel Settecento, il problema potrebbe essere posto nel senso di eliminare la portualità veneziana. Diventa difficilissimo entrare o uscire dalla laguna, al punto che persino l’Arsenale entra in crisi, quale cantiere, perché i fondali disponibili dalle parti di Castello sono insufficienti per il transito dei nuovi vascelli: i quali possono sì essere costruiti e varati, ma non allestiti completamente perché pescherebbero troppo. Ci s’inventa un complicato e costoso sistema, in verità d’importazione concettuale olandese, chiamato “cammello” per portare gli scafi in mare, dove, ancorati sui fondali argillosi e quindi buoni tenitori, al largo di Piave Vecchia e di Malamocco possono venire completati.
Soluzione accompagnata dalla riduzione dimensionale delle nuove costruzioni navali: quelle veneziane del Settecento, come noto, sono più piccole delle corrispondenti estere e il motivo è solo questo. Forse l’Arsenale andrebbe trasferito altrove, visto che all’epoca non si dispone dei mezzi per procedere allo scavo di canali di navigazione adeguati. Nel XVIII secolo, dunque, la portualità veneziana soffre gli stessi, identici, problemi di adesso. La laguna, invece, a dispetto dei colossali interventi appena ricordati, è vittima di un processo diametralmente opposto: invece di venire invasa da masse d’acqua incontrollabili, lo era da enormi quantità di detriti e fango che la stavano interrando, avviandola all’estinzione. La ragione per cui, tra i vari interventi del Regno Italico su sollecitazione diretta dello stesso Napoleone Bonaparte allora Imperatore dei Francesi e Re d’Italia, ci sono l’allungamento delle dighe alle Bocche di Porto, sia di San Nicolò di Lido che di Malamocco, quest’ultima da un bel po’ l’unica rimasta utilizzabile ai fini della portualità. È noto che risalgono allo stesso periodo anche grandi opere all’interno dell’Arsenale, con la realizzazione tra l’altro di un nuovo rio di entrata/uscita per consentire il movimento dei vascelli direttamente da e verso San Nicolò.
Quanto al porto, questo è sempre stato “diffuso” a Venezia dove anche nell’immaginario collettivo ogni fondamenta e riva d’acqua poteva diventare ormeggio. Vero in epoche dove le navi pescavano pochissimo e presentavano bordo libero e opera morta limitati, lo resta anche successivamente, quando gli ormeggi risultano sparpagliati tra le isole. Dal Lazzaretto Nuovo, quindi all’altezza di Sant’Erasmo, al canal de Maran, San Nicolò, Lazzaretto Vecchio, Poveglia, Malamocco, San Pietro, Spignon e Fisolo, ormai nella laguna sud: si parla di almeno una dozzina di miglia nautiche in linea d’aria, più che meno. La superficie impegnata è persino superiore al fronte d’acqua dell’area portuale odierna o comunque paragonabile, mentre non lo sono numero e dimensioni delle navi e volumi delle merci.
La risposta all’interramento e alle problematiche della navigazione data dai veneziani in passato, comunque, fu duplice: da un lato grandi lavori tesi a modificare la morfologia lagunare, dall’altro il porto diffuso, per sfruttare al meglio l’acqua disponibile. Non lasciarono avanzare la terra, perché dall’acqua dipendeva la loro vita. Il porto rappresentava la fonte di sostentamento e andava preservato. A ogni costo. Abbiamo qualcosa da imparare da tale lezione?
La prima osservazione è che conoscevano la loro storia. Sapevano bene che la città era nata porto a causa della scelta marittima compiuta all’origine. Non avendo terra, scelsero il mare, il che implicava costruire e usare navi su rotte a lunga distanza, per intercettare i flussi commerciali che, da sempre e ancora oggi, transitano lungo l’autostrada liquida dell’Adriatico.
La seconda è che non avevano alcun timore di agire. Francamente, fatte le debite proporzioni e vista la diversa caratura della tecnologia a disposizione, il M.o.S.E è assai modesto rispetto alle imprese di Sabbadino e al Taglio di Porto Viro.
La terza è che erano capaci non solo di spinta culturale, cioè di sfruttare la conoscenza accumulata per scovare nuove soluzioni innovative secondo processo che genera progresso continuo e cambia le coordinate dell’esistenza; ma anche di costruire scenari annidati, cioè non lineari secondo un univoco rapporto di causa-effetto bensì con più esiti diversi. Da qui il porto diffuso settecentesco.
Oggi noi dobbiamo rispondere a domande analoghe a quelle dei nostri predecessori, anche se le conseguenze dei processi, su scala globale e di quanto di specifico innescato dai lavori novecenteschi, hanno prodotto effetti opposti: non più interramento, bensì allagamento; espansione del mare invece di suo arretramento. L’approccio, però, dovrebbe tener conto degli insegnamenti acquisiti e cercare di sfruttare la spinta culturale per elaborare scenari annidati capaci di condurci a soluzioni innovative. Se il M.o.S.E. si è rivelata una buona soluzione per la salvaguardia, andrebbe finito e mantenuto in efficienza pronti ad adeguarlo al mutare degli scenari, adesso bisogna affrontare la questione porto. Perché senza porto non esiste Venezia in quanto città reale. A meno che non la si voglia ridurre a teatro da Commedia dell’Arte, con abitanti quali figuranti/attori per spettatori generati da flussi caotici di visitatori inconsapevoli. Come ormai sta diventando. La risposta c’è già nella Storia e si chiama porto diffuso.
Bisogna, cioè, uscire dalla logica dell’infrastruttura unica concentrata per sparpagliarla nello spazio, provvedendo a collegare le varie parti con adeguate interconnessioni veloci. È palese che tale “diffusione” solo in parte può riguardare la laguna. Per via dei fondali e del M.o.S.E. Pensiamola allora all’esterno. In altura. Invece di portare le navi, sempre più grandi, dentro immaginiamo di farle approdare su terminali esterni dove arrivino trasporti, che possono anche proseguire sino a distanze illimitate. Servono Porti d’Altura, il plurale non è casuale, separati per container, merci, prodotti industriali e passeggeri, collegati con binari ferroviari alla Terraferma. Binari che potrebbero essere subacquei. Se esiste da anni l’Eurotunnel sotto la Manica forse non è un sogno folle.
Proviamo a vederlo con gli occhi della mente: piattaforme là dove i fondali sono alti per Grandi Navi e Portacontainer Giramondo che scaricano persone e merci che prendono un treno il quale può andare dove si vuole. In città come nella Pianura Padana, o direttamente in Germania, Francia, Spagna, ovunque. Dall’Adriatico al Baltico, al Mare del Nord, all’Atlantico, alla Penisola Iberica e alle pianure eurasiatiche con deviazione nei Balcani e oltre, fino al Mar Cinese: niente di più delle antiche vie dell’Ambra, di Eracle, del sistema delle vie della Seta. Navi e treni, che sia questa la risposta?